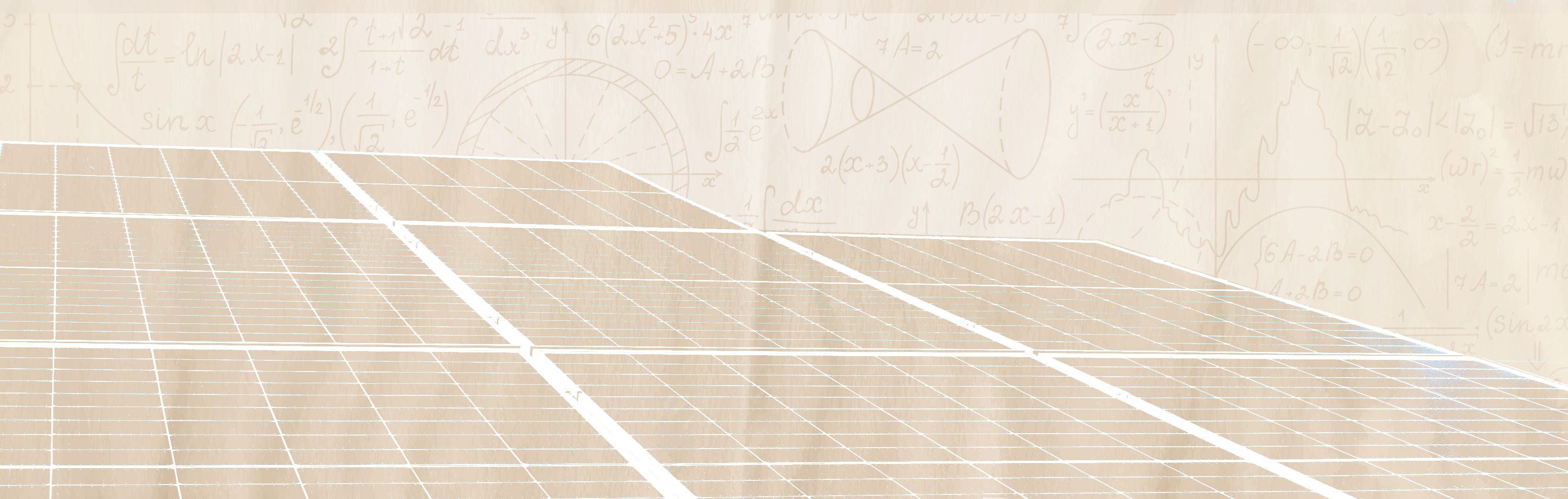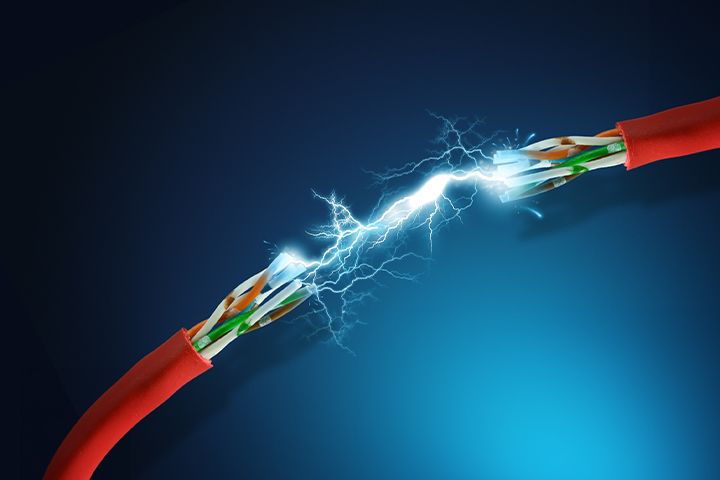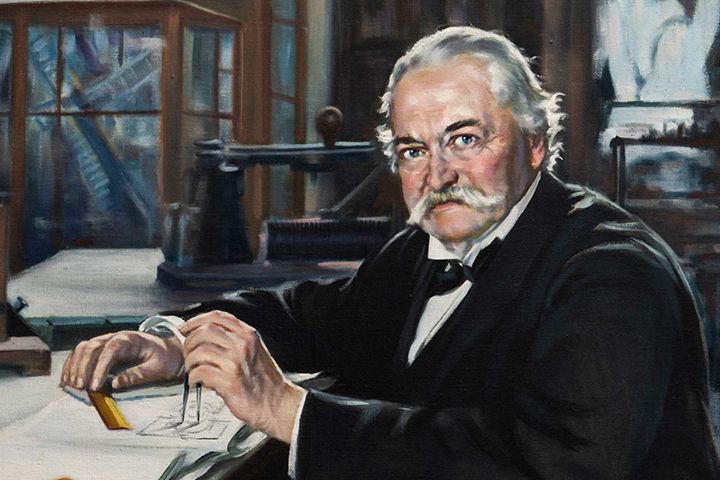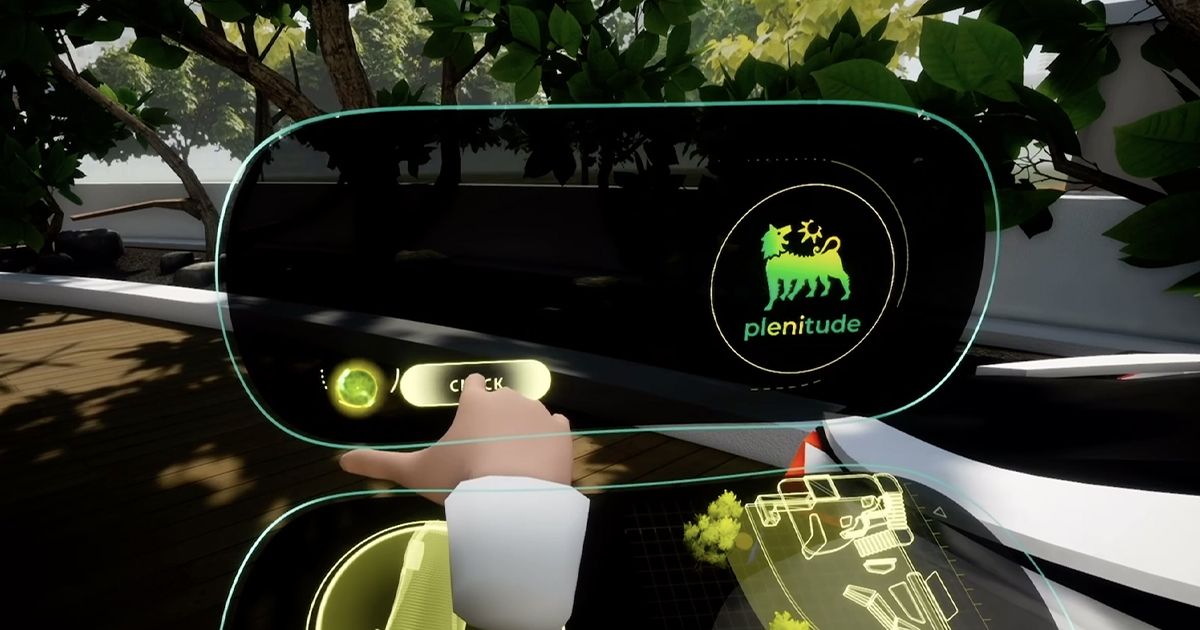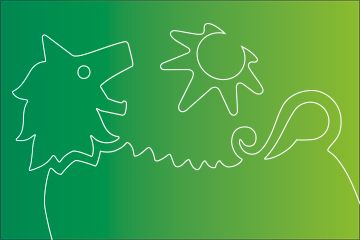Tanti contenuti, un solo magazine che racconta quanta energia impieghiamo oggi per progettare il domani. Accedi agli approfondimenti su innovazione, sostenibilità e su tutto quello che accade in Plenitude.
Non perderti le ultime novità
I nostri video in evidenza

Vedi tutti
Storie di Business
Innovazione
Sostenibilità
Persone
Nessun contenuto da visualizzare